Nella collana «Guide per la prassi ecclesiale», l’Editrice Queriniana ha appena pubblicato Riti corretti,
di Tom O’Loughlin.
Nella sua attività di insegnamento, il teologo di origine irlandese adotta una prospettiva eminentemente storica e incentra il suo lavoro sulla dinamica della tradizione in teologia. Dopo essere stato il primo docente di teologia storica all’Università del Galles, dal 2009 ricopre l’incarico di professore di teologia storica all’Università di Nottingham. In questo senso, i suoi interessi vertono sulla prassi del culto cristiano e su come la liturgia abbia svolto – e svolga tutt’ora – un ruolo complesso nella crescita dell’autocomprensione ecclesiale. Lungo i secoli, riti e sacramenti hanno sempre interagito con la teologia formale, e l’hanno fatto in una miriade di maniere, secondo percorsi cioè molto più complessi e sorprendenti di quanto non potrebbe suggerire il vecchio adagio Lex orandi legem statuat credendi
. Per converso, i cristiani di ieri e di oggi recuperano e “riciclano” il passato, onde dare senso all’esperienza presente nella liturgia. Dalla Prefazione all’edizione italiana del testo di O’Loughlin riportiamo qui alcuni stralci, per intuire le potenzialità di cui il testo è capace.
Tom O’Loughlin punta l’obiettivo sull’arte del celebrare. Perlustra il campo in lungo e in largo, percorrendo vie non convenzionali. Ritorna con piglio critico su questioni fondamentali, sollevando domande di nuovo conio. Pagina dopo pagina, pur usando un tono colloquiale e dando voce a riflessioni pacate, non manca di mostrarsi esigente: ci sfida a osservare le nostre liturgie con occhio disincantato, anche a costo di infrangere qualche tabù. Gli riesce così di tracciare una mappa complessiva e di allungare una bussola a lettrici e lettori, per sapere come muoversi.
In questa postilla conclusiva, ripercorrendo in diagonale il tragitto segnato dall’autore, proveremo a ricondurre a qualche nucleo generatore i densi contenuti sviluppati in questo The Rites and Wrongs of Liturgy – un gioco di parole, nell’inglese del titolo originale, tanto simpatico quanto intraducibile.
Valutare la liturgia? Dissacrante ma non troppo
E così l’imperatore si mise alla testa del corteo solenne, sotto lo splendido baldacchino. E tutta la gente che era per le strade e alle finestre esclamava: «Come sono fuor dal comune i nuovi vestiti dell’imperatore! Che stupendo strascico porta alla veste! Come tutto l’insieme gli torna bene!». Nessuno voleva dare a vedere che nulla scorgeva. «Ma non ha niente indosso!», gridò a un tratto un bambinetto (Hans Christian Andersen, Il vestito nuovo dell’imperatore, 1837).
«Non ha niente indosso!», sembrano urlare impertinenti le pagine di questo libro: come l’imperatore della fiaba di Andersen, il rito è nudo!
La prospettiva, insolita, di esporre le cose del rito nella loro cruda nudità, per più di qualcuno potrebbe suonare meschina. Blasfema e dissacrante, per qualcun altro. Veniamo in effetti da una lunga fase storica in cui le cerimonie potevano essere soltanto “valide” oppure “non valide”, ma non potevano essere giudicate più o meno “buone” – riconoscendo una gradazione di efficacia. Vigeva un approccio dogmatico essenzialista, per cui la sostanza del rito era immunizzata dagli accidenti umani: condizioni di persone, di tempo, di spazio, di azione, di percezione corporea, di linguaggio, di opportunità… Se gli orpelli c’erano (eccome!), aumentavano magari il potenziale didattico o il tasso di solennità delle “cerimonie”, ma non intaccavano il nocciolo duro del rito. Forse è per questo che la nozione di “buona liturgia” – categoria tanto nuova quanto scomoda per la teologia cattolica – ci suona ancor oggi perlomeno inopportuna. Misurare la qualità del celebrare sembra un’eresia!
E poi, se pure accettassimo di spogliare la liturgia della sua corazza difensiva, rendendola vulnerabile al giudizio umano, subito ci si presenterebbe il problema maggiore: stabilire una griglia di valutazione. Quali parametri dovremmo usare, quale unità di misura? Come il bimbetto di Andersen in mezzo alla folla, O’Loughlin non si lascia intimidire dalle convenzioni: mette al bando un criterio di autorità esterna o di antichità storica, smentisce il canone della sacralità fine a se stessa, evita di cedere alla conformità alle rubriche, sceglie di scansare l’estetica. Nessun volo pindarico. Con una buona dose di pragmatismo (o di understatement britannico, se vogliamo), si ispira ai criteri di Dieter Rams, adattandoli alla bisogna. Quelli che il professore di teologia storica a Nottingham ci propone sono criteri orientativi e linee-guida, non slogan promozionali o ricette preconfezionate; tantomeno un rigido decalogo calato dall’alto. Sono una griglia aperta di regole pratiche che si intrecciano l’una con l’altra.
Anzi, si osservi: buona parte di quei dieci princìpi individua delle realtà costantemente tese fra un troppo e un troppo poco, un dissidio fra polarità opposte – sacro e profano, universale e locale, gravità e leggerezza, legge e libertà, inclusione e separazione, identità e apertura, natura e grazia, umanità e divinità… – che non attende di essere risolto con un taglio netto. Al contrario, sono polarità da mantenere sempre in una sana tensione, polarità fra le quali, se si tratta di patteggiare volta per volta, lo si fa alla ricerca di un equilibrio dinamico. 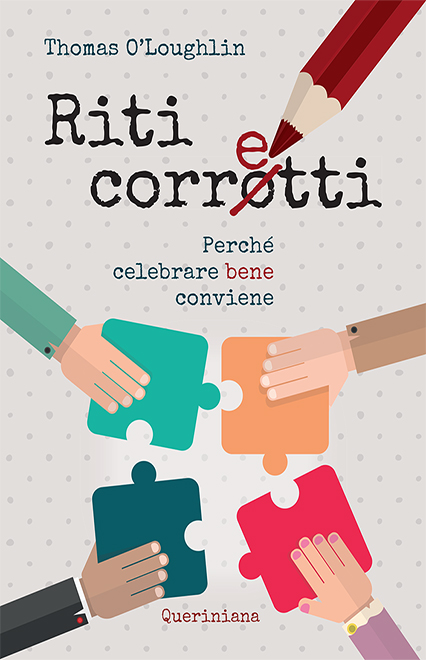
Lo strascico invisibile sotto il baldacchino
Torniamo all’imperatore della nota fiaba di Andersen, che alla fine resta in mutande. Qual è il problema, alla radice? È la sua vanità, condita dalla sua credulità? Vuole fare sfoggio di opulenza, forse? Ci sembra suggestivo pensare che il sovrano punti all’eccellenza: aborrisce abiti dozzinali, d’accordo, ma rifiuta anche un abbigliamento da comuni mortali; brama vesti nobili, certo, ma ancora non basta. Devono essere capolavori dalle fogge sfarzose e realizzati con stoffe dalle proprietà mirabili: devono essere quanto di più lontano esista dalla gente ordinaria. Più che di gusti personali, è una questione di ruoli, di gerarchie, di sangue blu, di distanze da sottolineare: noblesse oblige. Quale miglior segnale dell’abito? L’intervento dei due truffatori ottiene di esacerbare questa fissazione, facendo cadere nel ridicolo il sovrano insieme ai suoi cortigiani. L’esclamazione del piccino che, digiuno di cerimonie, denuncia la nudità dell’imperatore ha il sano potere di smascherare la farsa e di riportare la folla alla realtà (mentre i dignitari del corteo, si osservi, proseguono tronfi e imperterriti per la loro strada, «con un’andatura ancora più maestosa»). Il contrasto esasperato fra aristocrazia e popolino, con le buffe peripezie e le assurdità imbarazzanti che ne derivano per il borioso imperatore, evoca simbolicamente in qualche modo un’altra opposizione: quella fra “sacro” e “profano”. O’Loughlin vi ritorna sopra con insistenza: egli stigmatizza una liturgia solenne che si pretende fuori del tempo, nonostante il Dio cristiano si sia calato nella storia e immerso nella vita ordinaria. Questo punto merita alcune precisazioni, perché una contrapposizione secca fra sacro, da una parte, e vicinanza di Dio (incarnazione del Verbo in Gesù di Nazaret), dall’altra, ammesso che sia necessaria, non va forzata. Lo dice O’Loughlin stesso: anziché approfondire il solco di un dualismo insanabile, occorre costruire ponti fra le due sponde. Con sapienza pastorale, come ora vedremo.
Nella vita di tutti i giorni, noi di solito, mossi dal bisogno o dal desiderio, facciamo delle azioni per modificare la realtà e pronunciamo delle parole per esprimere la realtà e i suoi significati. Quando celebriamo, invece, non solo insceniamo gesti inusuali e ci scambiamo frasi prefissate, ma rimescoliamo le carte, invertendo esattamente l’effetto dei linguaggi verbali e non-verbali: compiamo azioni che parlano e diciamo parole che agiscono. Nel rito
– da un lato, compiamo dei gesti che sono perfettamente “inutili”, “improduttivi” (non servono a modificare la realtà in base al nostro bisogno o desiderio) e pronunciamo formule che non “rappresentano” la realtà (non servono anzitutto a descriverla per come è);
– dall’altro lato, proprio per questo, i gesti che facciamo sono così intensamente simbolici che esprimono ciò che Dio sogna per noi e le parole che proferiamo sono così potenti che operano sulla realtà, modificandola («Io ti battezzo» ottiene di rendermi un cristiano; «Questo è il mio corpo» non descrive uno stato di fatto, ma muta il senso e la realtà di un pezzo di pane).
Proprio perché sono sottratte al loro uso comune, ordinario, parole e azioni nella liturgia – inserite cioè in un contesto opportuno, distinto dalla vita di tutti i giorni – sono messe in grado di far entrare i celebranti in una esperienza non comune: stra-ordinaria. Solo destrutturando il mondo del linguaggio normale emerge la possibilità che il divino – il Dio trinitario, che è Padre, è Figlio ed è Spirito – torni a darsi a noi. Solo se ci è consentito di mollare la presa rispetto alla nostra esperienza ordinaria (manipolabile, padroneggiabile, sottoponibile a calcolo umano), una volta che ce ne siamo spossessati lasciamo spazio a una Presenza altra (fondante, gratuita e indeducibile), pronti ad accoglierla.
© 2020 by Teologi@Internet
Forum teologico
diretto da Rosino Gibellini
Editrice Queriniana, Brescia (UE)